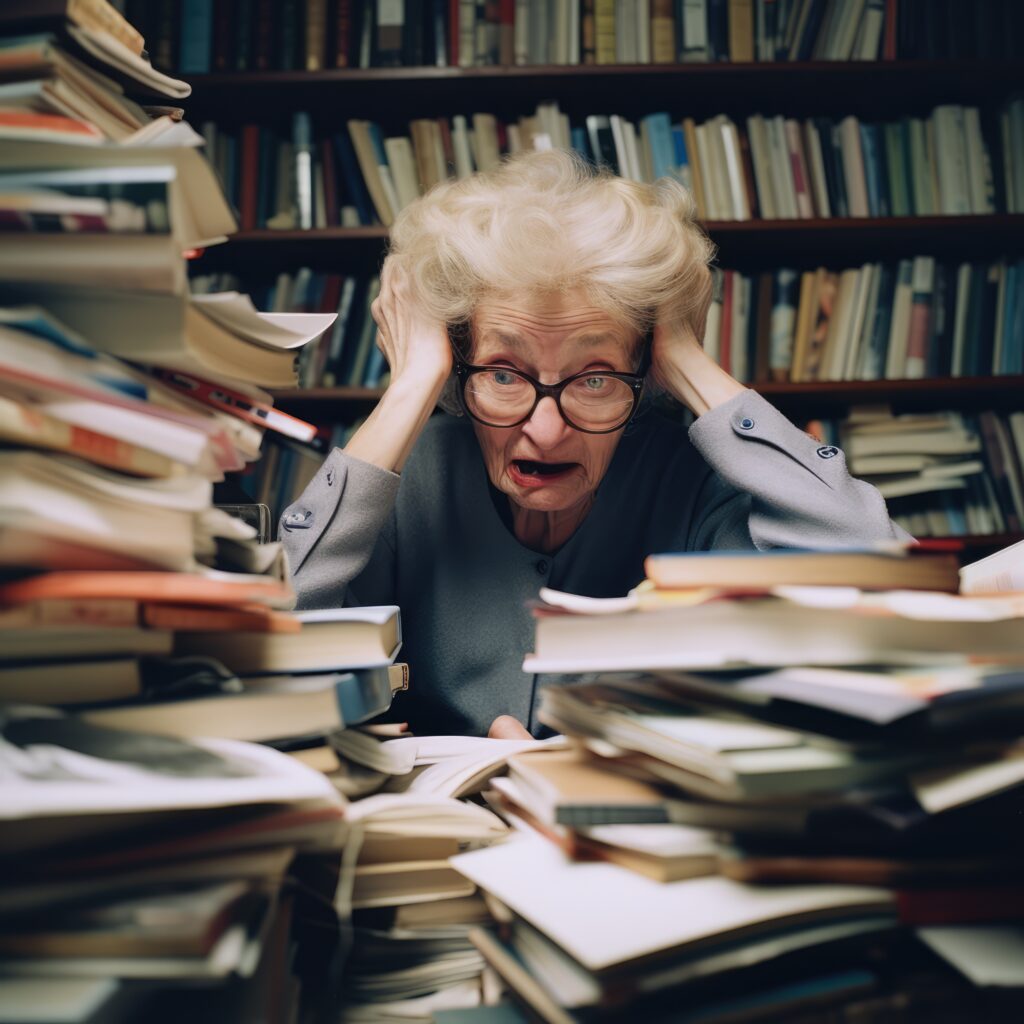
UDA senza Stress
Sei alle prese con l’UDA per l’esame di abilitazione? Ti stai preparando per il concorso a cattedra? Niente panico. In questo articolo ti illustrerò come progettare un’unità di apprendimento in maniera semplice e veloce. In particolar modo, ti mostrerò come renderla coerente e consistente.
Tavola dei contenuti
Cos’ è un’ UDA
L’unità didattica di apprendimento (UDA) è un percorso formativo interdisciplinare volto a far sviluppare determinate competenze. Nella pratica, i docenti progettano situazioni-problema che i ragazzi dovranno risolvere tramite l’applicazione di comportamenti adattivi (competenze).
In dettaglio, l’unità di apprendimento è quel documento progettuale in cui i docenti, partendo dal fabbisogno formativo della classe, dovranno indicare:
- le competenze che si vogliono far apprendere (obiettivi finali)
- gli strumenti e metodi che si vogliono utilizzare
- il tipo di lavoro che i ragazzi dovranno compiere
- il tipo di verifica e valutazione da utilizzare.
Inoltre, dovranno spiegare ai ragazzi, in maniera chiara e semplice, il lavoro in itinere e il prodotto finale che dovranno produrre (consegna).
La commissione d’esame come valuta l’UDA?
Sulla base della mia esperienza con diversi corsisti, è emerso che le commissioni utilizzano i seguenti criteri per valutare le UDA dei candidati:
- coerenza interna della progettazione;
- consistenza delle metodologie didattiche;
- consistenza delle metodologie valutative.
Le parti dell’UDA dovranno essere coerenti e verosimili. Se ad esempio sviluppi competenze sociali, le metodologie didattiche adeguate saranno di tipo cooperativo (cooperative learning), e la valutazione dovrà contenere indicatori che misurino le abilità sociali.
Quando si parla di consistenza, s’intende la “concretezza”, cioè la “corrispondenza alla realtà”. Considera che la commissione, quando effettua la valutazione, immagina la tua progettazione “calata” nel contesto reale.
Prima di addentrarci nei particolari dell’Unità di Apprendimento, ricorda di seguire queste due regole:
- non scrivere troppo, non strafare; attieniti a cose semplici, chiare e realistiche.
- Motiva sempre le tue scelte: al di là della quantità, soffermati sulla qualità e motiva sempre quello che progetti in ogni fase dell’UDA.
Leggi i miei libri sulle UDA e sulle Lezioni simulate
Contesto e destinatari
Parti da situazioni a te familiari. Se hai già fatto supplenze, immagina i contesti su cui hai esperienza. Dunque, rifletti sul macro contesto e micro contesto socio – economico delle scuole che conosci. Sulla base di ciò, scegli quali competenze è necessario far apprendere ai ragazzi (fabbisogno formativo). Esempio: se il contesto è a forte presenza straniera, motiva che intendi sviluppare competenze riguardanti il dialogo, l’inclusione, la partecipazione democratica alla vita comunitaria, cioè la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 2018). Ricorda sempre di indicare il numero dei componenti della classe (ti tornerà utile per definire le metodologie cooperative) e i casi BES, citando le relative documentazioni (PDP e PEI)
Gli obiettivi generali dell’Unità di Apprendimento
In questa sezione, dovrai esplicitare quali sono i macro-obiettivi dell’UDA. Non fare un elenco troppo lungo, poiché risulterebbe irrealistico sviluppare troppe competenze. Gli obiettivi generali dell’UDA si ricavano dalle seguenti fonti.
In queste fonti troverai competenze trasversali, cioè comuni a più discipline.
Chiaramente, non andrebbe ricopiato passivamente quanto trovi scritto. Dovresti adattare le competenze generali al contesto di partenza. Domandati: il contesto – classe che ho decritto all’inizio, che tipo di competenze ha bisogno di sviluppare (fabbisogno formativo)?
Considera che nella realtà pratica, la scelta delle competenze – obiettivo, è definita dal Consiglio di classe a inizio anno. Se emerge carenza di certe competenze, allora si dovrà progettare di farle apprendere ai ragazzi tramite un lavoro didattico attivo. Questa è la finalità specifica dell’Unità di Apprendimento.
Gli obiettivi specifici dell’UDA
Nei vari modelli di UDA (spesso nella seconda sezione) troverete riferimenti agli obiettivi specifici dell’azione didattica. Questi sono obiettivi intermedi, cioè strumentali (conoscenze e abilità) volti a raggiungere le finalità generali dell’UDA (le competenze obiettivo o finalità generali). Ti mostro due esempi.
ESEMPIO 1
Per una UDA di taglio storico, l’obiettivo generale potrebbe essere:
comprendere le radici del presente, attraverso la discussione critica tra diverse prospettive, al fine di costruire ruoli di cittadinanza attiva.
Gli obiettivi specifici strumentali saranno configurati come segue:
1. saper analizzare con spirito critico i fatti storici; riconoscendo collegamenti pertinenti;
2. saper riconoscere la natura delle fonti e i loro rapporti dialettici;
3.comprendere l’evoluzione dei fatti storici e di come questi si evolvono fino ai giorni nostri .
ESEMPIO 2
Per un’ UDA di taglio filosofico, gli obiettivi generali potrebbero essere:
1. capacità di argomentare vari punti di vista riconoscendone la validità, in un’ottica democratica di comprensione delle differenze culturali;
2. saper lavorare in gruppo e gestire eventuali conflitti in una prospettiva inclusiva.
Gli obiettivi specifici strumentali saranno i seguenti:
1. saper contestualizzare le risposte filosofiche, riconoscendone punti di forza e limiti;
2. riconoscere e validare le opinioni dei compagni;
3. saper esprimere le proprie opinioni, argomentando in maniera critica.
Questi obiettivi fanno parte, in versione semplificata, di un’UDA presentata ad un esame di abilitazione. Al di là della tipologia o quantità di obiettivi, quello che qui ci interessa è la coerenza tra i primi (competenze – obiettivo) e i secondi (abilità e conoscenze strumentali). Gli obiettivi specifici, insomma, ci servono per raggiungere quelli generali. Ma da dove derivano gli obiettivi specifici dell’unità di apprendimento? Puoi far riferimento alle Indicazioni Nazionali, per la disciplina di riferimento. Ricorda sempre che non è necessario e auspicabile (!) ricopiare. Il tuo lavoro dovrebbe essere quello di “declinare” queste abilità e conoscenze rispetto alle competenze generali che vuoi sviluppare.
Se hai bisogno di assistenza per l’estrazione della traccia e per l’elaborazione di UDA/Lezioni simulate, visita la mia pagina dei servizi cliccando sul link qui sotto👇👇👇👇
Leggi le opinioni dei docenti per il quali ho elaborato UDA e Lezioni simulate per gli esami di abilitazione e concorso:
Setting di apprendimento: materiali, strumenti e spazi
Questa è la sezione in cui elencherai strumenti fisici e tecnologici utilizzati: LIM; computer e/o tablet; libri cartacei o digitali; video; mappe concettuali o mentali; fonti cartacee oppure online come articoli o altro; utilizzo di software (videoscrittura o altro); piattaforme interattive (es.: Google moduli e classroom); traduttori online.
Accanto a questo gruppo, ti consiglio di dedicare uno spazio in cui motivi quali di questi strumenti sono volti all’inclusione dei BES. Nel caso di studenti con dislessia, potresti aggiungere la sintesi vocale, se utilizzata; o traduttori e video con sottotitoli, se vi sono studenti NAI. Per ogni scelta che operi, è sempre conveniente motivare. La commissione d’esame non è tanto interessata alla quantità di cose che scrivi, ma vuole vedere come utilizzi gli strumenti per gli scopi che ti prefiggi. Fai molta attenzione, poiché il tema dell’inclusione è imprescindibile.
Per ultimo, dovrai indicare gli ambienti (spazi) in cui si realizzerà l’azione didattica: aula, aula informatica, disposizione particolare dei posti se vi sono lavori di gruppo, altri luoghi atti a creare un ambiente costruttivo e inclusivo.
Attività e strategie dell’azione didattica
Siamo al cuore dell’unità di apprendimento. Qui dovrai motivare il tipo di lavoro che progetti per la classe. O meglio: quello che progetti di far fare agli studenti.
Per prima cosa, dovrai pensare ai tempi. Per un’UDA small, in genere si assegnano 6 ore. Puoi decidere di spezzettare queste 6 ore in ulteriori segmenti. Per fare questo, considera per quante ore settimanali è prevista la tua disciplina. Se insegni Storia e hai 2 ore settimanali, potresti pensare di suddividere le 6 ore in 3 fasi da due ore ciascuna, spalmate su tre settimane.
Successivamente, per ognuna delle tre fasi (gruppetti da 2 ore contigue), dovrai progettare e motivare le attività da svolgere (azione didattica). In genere, le commissioni sono orientate a valutare positivamente le azioni didattiche attive, quelle in cui gli studenti sono protagonisti. Le varie attività di cooperative learning (brainstorming, Jigsaw, etc.) si prestano benissimo a rendere gli studenti partecipi e consapevoli del loro apprendimento. Cerca di progettare attività semplici e fattibili, senza strafare: verrà giudicata positivamente la pragmaticità e la verosimiglianza della tua proposta.
Se prevedi attività di gruppo, motiva sempre perché decidi di fare così. Potresti far cenno a competenze sociali, di cittadinanza, di lavoro in team, di inclusione, reciproco aiuto, per sviluppare anche l’empatia, etc.
N.B. Se nella tua UDA vi sono casi BES, dedica uno spazio in cui motivi come s’inseriscono nelle fasi dell’azione didattica. Spiega come interagiscono nei lavori di gruppo, come gli vengono assegnati i compiti, se i gruppi sono eterogenei, se vi è l’insegnante di sostegno, se vi sono studenti stranieri (NAI) che necessitano di interagire tramite traduttori. Cerca di fare uno sforzo immaginativo e usa il buon senso.
Nelle fasi dovrai prevedere il tempo anche per la realizzazione del compito. Potresti chiedere di produrre una relazione, una presentazione multimediale, o un video. Prevedi un tempo congruo e realistico.
Per ultimo, assegna un tempo adeguato alla valutazione e all’autovalutazione. Importante è che il feedback del docente sia chiaro, pubblico (non parlo del voto, cioè del fatidico numero!) e compreso dai ragazzi, i quali avranno l’occasione per riflettere sui processi di metacognizione.
Modalità di verifica e valutazione
Il processo di verifica avviene sia in itinere (verifica formativa) sia alla fine del percorso (verifica sommativa). Questo significa che la valutazione esamina sia gli atteggiamenti e le operazioni delle varie fasi del lavoro degli studenti; sia il prodotto finale che essi devono produrre.
La valutazione formativa avviene attraverso griglie di osservazione o check list che servono a raccogliere dati da inserire nelle rubriche di processo. Se i ragazzi lavorano con jigsaw e brainstorming, dovrai utilizzare degli indicatori di osservazione durante il lavoro in classe. Successivamente, compilerai la rubrica di processo con gli indicatori pertinenti al caso.
La valutazione sommativa avviene tramite rubrica di prodotto. Se prevedi di assegnare una presentazione multimediale, tra gli indicatori da esaminare dovrai inserire riferimenti sia ai contenuti disciplinari, sia alle abilità digitali (aspetti formali e grafici della presentazione multimediale). Tra gli indicatori, è sempre bene mettere sempre un riferimento alla metacognizione, poiché essa è riferibile sia alle competenze dell’apprendimento permanente dell’UE, sia perché è una competenza trasversale.
N.B. Per gli studenti BES, prevedi di integrare la valutazione facendo riferimento anche alle significative modificazioni comportamentali, il grado di interazione e successivamente il conseguimento degli obiettivi previsti dal PDP o PEI.
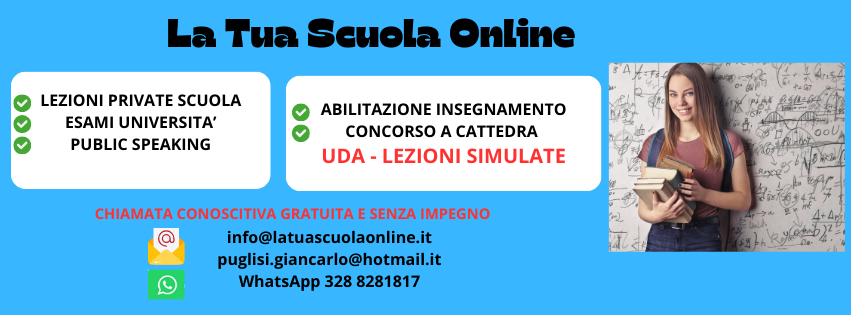






Lascia un commento